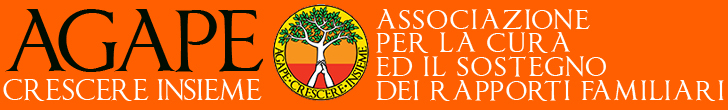di Carla Valeri
I servizi per la tutela dei minori costituiscono, all’interno dei più generali servizi sociali, un sistema di interventi, reti di professionisti, metodologie, dedicati a quelle famiglie in difficoltà, nelle quali sia presente un minore, e che a vario titolo necessitano di un supporto educativo, psicosociale, economico. Si tratta dello svolgimento sia di funzioni di assistenza, sostegno e aiuto nella genitorialità alle famiglie sia di funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte alle carenze nella gestione del ruolo genitoriale e in condizioni di «rischio evolutivo» del minore. Le condizioni concrete vanno dalle più gravi (abuso, violenza, violenza assistita), alla conflittualità coniugale nell’ambito della separazione, fino ai diversi aspetti della inadeguatezza genitoriale, agli interventi dedicati agli adolescenti, fino alle attività riguardanti l’affido e l’adozione. Ciascun Ente locale, (in particolare i Comuni), tramite i suoi servizi sociali, gestisce queste attività, che sono sempre realizzate nell’interesse dei minori, ma possono coinvolgere gli adulti piuttosto che i ragazzi. Parliamo di interventi di sostegno alla genitorialità, di valutazione delle competenze dei genitori nella cura dei figli, di consulenza a famiglie in difficoltà per crisi legate all’adolescenza dei figli, o a separazioni conflittuali, fino alla garanzia di un diritto di visita in uno spazio esterno alla casa per quel genitore che per diverse motivazioni contingenti o definitive, sia stato allontanato dalla possibilità di vivere con il minore. Gli interventi sono gestiti con diverse modalità, monitorati a livello regionale, e si avvalgono di diverse professionalità(psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, mediatori, neuropsichiatri ) che operano in rete e con scambi costanti, coinvolgendo spesso l’Autorità Giudiziaria (Tribunale Civile e Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare) e fanno tutti riferimento alle copiose normative nazionali ed europee relative all’assistenza alle famiglie e alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (tra le altre le Leggi 285/1997 e 328/2000 ).
Lavoro in uno di questi servizi e ho quindi un punto di vista molto particolare sulla famiglia e il suo stato di salute. Certamente un punto di vista parziale, ma molto intenso. Dal mio punto di osservazione osservo nuclei familiari sotto stress, spesso in condizione di povertà economica e frequentemente in condizione di povertà educativa. Famiglie spesso oppresse da una elevata conflittualità interna e da grandi difficoltà nella comunicazione. Osservo separazioni talmente conflittuali da portare i genitori a dimenticare il benessere dei figli, facendone oggetto di contesa o di ricatto. Talvolta l’atteggiamento del genitore contiene una richiesta al figlio di scegliere tra uno dei due genitori, di schierarsi. Vedo bambini poco curati da genitori affetti da disturbi psichici gravi, o da dipendenze di vario tipo, o in gravi condizioni di disagio economico, ma anche da persone troppo prese dalla propria realizzazione personale e dalla propria narcisistica realizzazione. Genitori che non riescono più a svolgere i loro compiti di cura e protezione, che non sanno contenere e offrire una base sicura. Questi servizi incrociano vite piene di risentimento, dolore, violenza trattenuta, incapacità a comunicare.
I piccoli protagonisti di queste stanze sono Bambini e Adolescenti sofferenti, confusi, risentiti. Ma resistenti. Colpisce nell’incontro con loro la voglia di parole, il desiderio di essere ascoltati, di capire l’adulto, di riaprire con lui un canale di comunicazione, di uscire da una dinamica relazionale viziata, patologica, carica di ansia, per accedere a colloqui autentici, con un adulto disposto ad ascoltarli e ascoltare le loro emozioni.
Gli operatori chiedono agli Adulti di guardare al conflitto in cui sono coinvolti con gli occhi del loro figlio: provare a mettersi nei panni del bambino, e con i suoi occhi guardare il mondo. Chiediamo loro di sintonizzarsi con il proprio figlio, una competenza del buon genitore che talvolta viene dimenticata, o a volte mai conosciuta. Chiedere ad un bambino si scegliere tra uno dei due genitori equivale a chiedergli di rinunciare ad una parte di sè, a spezzarsi per essere accettato dal padre o dalla madre. Chiediamo a questi genitori come si sentirebbero loro, nei panni del loro figlio, costretto a schierarsi.
Eppure, osservando questo piccolo microcosmo di famiglie, per fortuna una porzione minima della società, viene da pensare che quella rabbia, quella impulsività, il risentimento, la distrazione rispetto ai bisogni del figlio, non siano un fenomeno isolato e circoscritto che riguarda solo questo gruppo , a volte infelice, di famiglie. Sembra piuttosto lo specchio, distorto, ingrandito, esasperato, di una modalità relazionale prevalente nella comunità; impulsività, scarsa tenuta della frustrazione, incapacità a contenere e a proteggere i deboli, mancanza di rete interpersonale, poco ascolto, poca empatia.,, tutto questo non è molto lontano da alcuni atteggiamenti che coinvolgono l’ intera società.
Nell’ultimo libro di A. Cuzzocrea, “ Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un paese che non guarda al futuro” , viene evidenziata proprio la deriva di una società che i bambini se li sta dimenticando, o li vuole uguali ai grandi, o li zittisce con prodotto e merci , proprio come fanno alcuni genitori , che vengono agli incontri con i figli con tanti giochi nuovi, ma poi non sanno cosa dire loro in quell’ora..
Dal particolare punto di vista da cui osservo il mondo delle famiglie, il pensiero corre a come si potrebbe riparare questa distanza, questa incapacità di riconoscere il valore sociale globale dell’infanzia, non solo per la società, ma per ciascuno di noi: serve a tutti noi una buona educazione all’ascolto dell’altro, all’uso dell’empatia, il riconoscere le identità più che le diversità, un’ educazione alla gestione dei conflitti, una riflessione sulla violenza e su come gestirla, come si può imparare la mediazione e la negoziazione di fronte e diversità di vedute o di interesse.
Cosa vuol dire infanzia, di cosa hanno veramente bisogno i bambini e gli adolescenti per crescere, come possiamo riconoscere le emozioni che ci spingono ad agire? Una buona educazione emotiva rappresenta una prevenzione reale ed incisiva per le crisi che le famiglie, e l’intera comunità, sembrano incontrare sempre più spesso nel loro lavoro di cura dei più piccoli.
Carla Valeri Roma, 26.9.2021